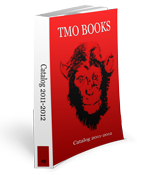“I dreamed I was the president of these United States…” questo è l’incipit di The day John Kennedy Died, terza canzone della scaletta del concerto che Lou Reed ha tenuto lo scorso lunedì 27 febbraio a Milano. Parole sulle quali il pubblico variegato (spaziava da sessantenni vestiti con cinture chiodate e jeans strappati a giovani dall’aspetto innocente che non erano probabilmente ancora nati quando usciva uno degli album più significativi dell’era rock, Transformer) del teatro Ventaglio ha letteralmente osannato il cantante.
Sembrava quasi che avessero realizzato solo in quel momento chi si trovavano davanti sul palco. Già, il palco di un teatro, l’ambiente dove meno mi sarei mai immaginato di trovare Lou Reed e la sua band. E invece si è rivelato essere il suo habitat ideale, l’arena perfetta da dove poter dirigere con gesti e voce la sua musica composta di poesia, bassi e alti, ritmo cadenzato, ma anche tante improvvisazioni e assoli. Lo cercavano spesso le luci del teatro e insieme a loro gli occhi dei presenti, come se la sua esibizione potesse essere l’ultima, una sorta di canto del cigno.
Ma l’ormai sessantaquattrenne ha invece a più riprese dimostrato di avere ancora l’energia di un tempo. Quando, tornato in scena per concedere un bis, iniziava a suonare quei tre accordi memorabili composti al tempo dei Velvet Underground e intonava quelle magiche parole “Standing on the corner, suitcase in my hand…. sweet Jane”, ci faceva tornare indietro ai tempi della sua gioventù. Mentre precedentemente, con una selezione di pezzi inediti o meno famosi, ci aveva fatto partecipe delle sue esperienze di vita, del suo viaggio nella musica, dal punk al glam, passando per il rock puro e l’improvvisazione jazz.
Il risultato è stata una miscela di pezzi veloci (Street Hassle su tutti), rivisitazioni di canzoni più datate come Red Joystick e ballate melodiche (Who Am I e Tell It to Your Heart), entrambe accompagnate dalla voce acuta e soave del fedele e bravissimo bassista-corista Fernando Saunders, che non ha fatto rimpiangere la Nico del tempo dei Velvet Underground. Se il contrabbassista Rob Wasserman riusciva invece nell’intento di ricreare atmosfere lugubri col solo uso dei polpastrelli, il batterista Tony ‘Thunder‘ Smith (l’ultimo arrivato alla corte della band diretta da Reed) si impegnava a rendere impossibile la staticità dei corpi di chi, come me, aveva deciso di godersi lo spettacolo in piedi, se non altro per omaggiare l’icona.
I commenti finali all’uscita del teatro di chi non era già corso ad acquistare magliette con stampate le foto del rocker di Long Island o il logo della sua prima famosa band il cui titolo venne preso da quello di un libro giallo trovato per caso nella spazzatura, sono stati discordanti. C’era chi aveva sperato in una performance più lunga, chi magari di rivederlo truccato o con gli occhali da sole a coprirgli le rughe, forse per avere almeno l’illusione di tornare a quei fantastici (per il glam-rock) anni ’70, chi si era immaginato una selezione delle canzoni più famose. Ma questo è il concerto come l’aveva inteso lui, Lewis Firbank Reed, questo è il messaggio che ci voleva dare: “It’s just a perfect day”. Quello a cui avevamo appena assistito era stata l’espressione di quello che aveva dentro, di quello che voleva trasmettere il ragazzo sessantaquattrenne di adesso. I fans più attenti lo hanno capito.